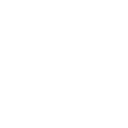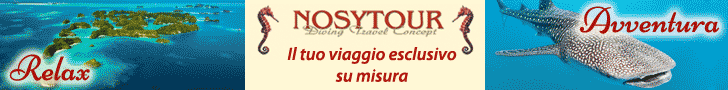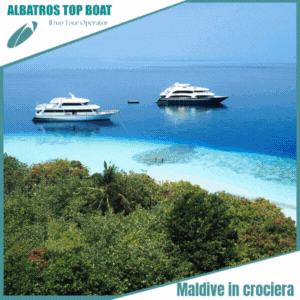PARTE 1 – Genesi e caratteristiche del progetto
Sono passati 23 anni da quando decisi di dar vita ad un progetto di ricerca su una specie di squalo che da sempre mi affascinava per il suo comportamento sociale: lo squalo martello smerlato (S. lewini).
Ad aprile 2003 avevo partecipato a quella che sarebbe stata la mia ultima spedizione in Sud Africa, per osservare e studiare gli squali bianchi, ed era mia intenzione cambiare obiettivo di ricerca: anche perché, non volevo più utilizzare tecniche di avvicinamento che modificassero il comportamento naturale degli animali, come ad esempio il chumming. Avevo intenzione di dedicarmi ad una specie che, nel mio periodo lavorativo alle Maldive, mi aveva particolarmente affascinato: volevo approfondire lo studio delle aggregazioni (denominate schooling) di Sphyrna lewini: soprattutto, volevo lavorare approcciando gli animali in maniera naturale, evitando di modificare il loro comportamento.

La spedizione esplorativa in Sudan
All’inizio dell’estate 2003, ho iniziato a cercare un sito di studio che fosse relativamente vicino all’area mediterranea, ma che avesse uno scarso impatto turistico: venni quindi a sapere che i reef sudanesi ospitavano schooling di S. lewini: ero pronto quindi per organizzare una “spedizione esplorativa“, necessaria per capire se c’era la possibilità di realizzare un progetto di ricerca in quell’area. Ero però molto scettico, soprattutto perché in quegli anni, il turismo subacqueo nel Mar Rosso, era al suo apice.
Con l’amico Sergio Corti (Aquasport-Lecco), riuscimmo ad organizzare, per ottobre 2003, la “Spedizione Zero“, appoggiandoci ad un’imbarcazione a noi sconosciuta: l’Elegante di Claudio Scarpellini. Proprio quella casuale scelta risulterà negli anni una delle chiavi del successo: infatti, nonostante ottobre non fosse il periodo giusto per l’osservazione delle schooling in Sudan, Claudio fu di grande aiuto per comprendere le potenzialità dei reef sudanesi: in quella settimana di ottobre, Claudio fece l’impossibile per farmi vedere gli squali martello e per darmi tutti gli strumenti utili a comprendere se si potesse iniziare un progetto di ricerca in quell’area. La passione che ci univa per il mare, per la subacquea e per gli squali martello, negli anni sarebbe stato un collante indissolubile, che ancor oggi unisce me e Claudio in un’amicizia fraterna.
Il progetto Hammerhead Schooling Research
Al termine di quella spedizione, rientrato in Italia, con Claudio iniziai a organizzare la “Spedizione 1“: da allora le spedizioni organizzate e dirette in Sudan dall’Associazione di ricerca che presiedo, Danishark, sono state 20, sempre a bordo dell’Elegante, con l’aiuto dello storico equipaggio e dell’impagabile Claudio.
In questi 23 anni, le 20 spedizioni hanno battuto i 5 itinerari possibili in Sudan (classico, estremo nord, nord, sud e deep sud), concentrandosi su 16 reef, che per morfologia e correnti, garantiscono la presenza di schooling di S. lewini. Il progetto, denominato Hammerhead Schooling Research, ha come obiettivo lo studio delle aggregazioni di squalo martello smerlato (S. lewini) nel Mar Rosso centrale: il progetto, dalla sua nascita ad oggi, ha vissuto due fasi.
Prima fase del progetto (2004-2013)
La prima fase è iniziata con la “Spedizione 1” (marzo 2004) e si è arrestata nel novembre 2013, momento nel quale è uscita la mia prima pubblicazione su S. lewini in Sudan: la genesi dell’articolo scientifico, realizzato in collaborazione con altri due ricercatori (T. Storai e G. Boldrocchi), è durata quasi 10 anni: questo perché, allora come oggi, non esiste bibliografia scientifica su S. lewini, relativamente al Mar Rosso centrale e quindi, ogni teoria espressa nell’articolo, doveva essere oggettivata da riscontri diretti, che spesso hanno richiesto una specifica spedizione. L’articolo, pubblicato sulla rivista di Biologia Marina dell’Università di Cambridge (UK), è tuttora l’unico lavoro scientifico dedicato a S. lewini, nell’area del Mar Rosso sudanese.
Protocollo di ricerca
Il protocollo utilizzato per la raccolta dei dati di ricerca è focalizzato su 4 punti chiave:
- Osservazione diretta delle schooling e realizzazione di video
- Misurazione morfometrica degli esemplari di S. lewini, tramite Laser Measurement
- Utilizzo di telecamere stanziali posizionate sul reef, nei punti di aggregazione
- Realizzazione del database
Dopo aver realizzato le prime spedizioni in Sudan, iniziai a confrontare i dati e le caratteristiche etologiche di S. lewini da me osservati, con quanto veniva descritto, a partire dai primi anni ’70 da P. Klimley, famoso ricercatore statunitense che ha dedicato la sua vita allo studio di questa specie in Centro America: a differenza di quanto descritto da Klimley nei suoi articoli, in Sudan gli animali non presentavano segni di aggressione intraspecifica, non si osservavano le Cleaning Station e tantomeno la presenza nelle schooling di esemplari di dimensioni comprese tra 100cm e 140cm: inoltre, nel corso delle immersioni effettuate in Sudan, si osservava la presenza di un esemplare (denominato “Sentinella” o “Scout“), che svolgeva una particolare attività di nuoto, esternamente alla schooling: esemplare che in Centro America non veniva osservato.
Era quindi fondamentale comprendere se, esemplari della stessa specie ma di subpopolazioni residenti in siti diversi (e molto lontani tra loro), si erano evoluti diversificando alcuni aspetti etologici. Decisi quindi di organizzare delle spedizioni in Centro America, per applicare il mio protocollo di ricerca, al fine di assicurarmi che vi fossero davvero delle differenze etologiche tra le due subpopolazioni. Per questo, a partire dal 2011, sono state organizzate spedizioni nell’area del Centro America (Galapagos, Cocos, Malpelo e Socorro) e in altre aree del pianeta (Mozambico, Giappone etc.), con l’obiettivo di osservare le aggregazioni di S. lewini in siti diversi del pianeta, per confrontarne poi le caratteristiche etologiche con quanto osservabile in Mar Rosso.

Seconda fase del progetto (2014-2025)
La seconda fase del progetto è iniziata subito dopo la pubblicazione del primo articolo scientifico (marzo 2014) e si è conclusa nel marzo 2025, momento nel quale è stata discussa e pubblicata una tesi magistrale in Biologia Marina presso l’Università delle Marche, da parte di uno studente universitario che ha partecipato a spedizioni Danishark e ha realizzato il suo elaborato universitario concentrandosi sulle analisi statistiche dei dati raccolti in 23 anni di spedizioni Danishark.
Nella seconda fase del progetto, il protocollo è stato arricchito grazie all’utilizzo di un ulteriore strumento di ricerca, il ROV: il Remotely Operated Vehicle è un veicolo sottomarino che permette di fare osservazioni e videoriprese in remoto, ad oltre 100 metri di profondità, con qualsiasi condizioni meteomarine e anche in orario notturno.
Espansione in Arabia Saudita
A partire da aprile 2023, a causa della guerra civile scoppiata in Sudan, non è stato possibile organizzare spedizioni in quest’area del Mar Rosso e il Gruppo Danishark ha deciso di allargare l’area di studio anche al Mar Rosso saudita, nello specifico nell’area dei Farasan Banks: si tratta infatti di un’area del Mar Rosso speculare a quello sudanese, con moltissime caratteristiche in comune e che vede dei reef con morfologia molto simile ai reef sudanesi. Dal 2023 ad oggi sono state organizzate anche 3 spedizioni in Arabia Saudita e i dati raccolti sono stati inseriti nella tesi pubblicata a marzo 2025.
Bilancio complessivo del progetto
In questi 23 anni di vita del progetto Hammerhead Schooling Research, Danishark ha organizzato e diretto in totale 33 spedizioni, tutte con l’obiettivo di osservare le schooling di S. lewini: delle 33 spedizioni, 20 si sono svolte in Sudan, 3 in Arabia Saudita, 7 in Centro America e 3 in siti vari (Mozambico, Giappone, etc.). Sono state effettuate 817 immersioni in 52 siti, sempre in presenza di esemplari di squalo martello smerlato.
Le spedizioni Danishark si svolgono quasi sempre a bordo di imbarcazioni che navigano in siti specifici dove è possibile osservare le schooling di S. lewini: oltre allo staff Danishark, i posti barca sono disponibili a subacquei appassionati che vogliono approfondire le proprie conoscenze sui pesci cartilaginei e apprendere le migliori tecniche di immersione con questi splendidi animali marini.
Le centinaia di ore trascorse in immersione con questi animali ci hanno permesso di raggiungere una profonda conoscenza della biologia di questa specie e delle caratteristiche dei siti (morfologia dei fondali, correnti, etc.), che ospitano le grandi aggregazioni: è proprio la descrizione di questi due fattori (siti e correnti), che rende così affascinante il progetto Hammerhead Schooling Research.
PARTE 2 – Etologia delle schooling
In 23 anni di vita del progetto Hammerhead Schooling Research, con l’obiettivo di raccogliere dati utili alle pubblicazioni scientifiche, mi sono immerso oltre 800 volte con gli squali martello S. lewini, in 52 punti di immersione situati in 9 stati, tra Africa, Centro America e Asia: ho realizzato più di 100 ore di videoriprese sia di esemplari singoli di squalo martello (S. lewini), che di gruppi in fase aggregativa (schooling), riuscendo ad approfondire numerosi aspetti comportamentali e accumulando un’elevata esperienza in immersione con esemplari di questa specie.
Per poter avere una visione più ampia possibile della biologia di S. lewini e del fenomeno delle schooling, è stato fondamentale osservare questi animali in numerosi siti di aggregazione, estremamente eterogenei e lontani tra loro: questo mi ha permesso di confrontare gli aspetti etologici di S. lewini, ma mi ha anche permesso di poter confrontare e comprendere le differenti caratteristiche dei siti (morfologia, impatto delle correnti etc.), che permettono la formazione delle schooling.
Oggi, dopo 23 anni di studio e di osservazione diretta di questa specie, reputo di avere una profonda conoscenza dell’articolata biologia che la caratterizza, anche se sono ancora molti gli aspetti che non sono in grado di comprendere a pieno. Il confronto con alcuni ricercatori statunitensi e del Centro America mi ha permesso di comprendere le numerose differenze osservabili nel comportamento degli esemplari del Mar Rosso centrale, rispetto a tutti gli altri siti nel mondo.
Per poter illustrare questa specie di squalo martello, bisogna necessariamente analizzare in maniera approfondita due macro argomenti: la biologia di S. lewini e le caratteristiche dei siti di aggregazione.

Biologia di Sphyrna lewini
Lo squalo martello smerlato appartiene alla Famiglia Sphyrnidae, che annovera 9 specie di squali, caratterizzate dalla particolare forma della testa, appunto a martello. Sphyrna lewini ha una distribuzione geografica molto ampia, che spazia dall’Oceano Pacifico, all’Atlantico e al Mar Rosso.
Riproduzione e caratteristiche biologiche dello squalo martello
La riproduzione è di tipo vivipara placentata, cioè gli embrioni si sviluppano all’interno delle camere uterine, assumendo nutrimento direttamente dalla madre tramite una specie di cordone ombelicale (denominato appendicula): al termine della gestazione, che dura mediamente 8-9 mesi, vengono partoriti da 8 a 14 giovani squali, completamente indipendenti ed autonomi, in aree con scarsa presenza di predatori (ad esempio mangrovieti presenti lungo le coste).
Questa specie non ha la muscolatura della mandibola che gli permette di far fluire acqua sulle branchie, al fine di ossigenare il sangue: essa è quindi obbligata a nuotare costantemente, per rimanere in assetto e ossigenare il proprio sangue.
Evoluzione della forma a martello
Secondo le teorie evolutive, gli squali martello hanno sviluppato questa particolare forma del cranio, per 5 motivi:
- Idrodinamicità e assetto del nuoto: il cranio a “martello” aumenta l’idrodinamicità e stabilizza l’assetto dello squalo durante il nuoto, compensando in parte l’assenza della vescica natatoria
- Visione stereoscopica: la posizione (più esterna) degli occhi, aumenta sensibilmente il campo di visione dello squalo, aumentando l’angolo del campo visivo
- Capacità olfattiva: la posizione (più esterna) delle narici, permette allo squalo di “campionare” una quantità di acqua maggiore, migliorando le capacità olfattive
- Percezione elettromagnetica: la particolare forma del cranio permette un migliore posizionamento delle Ampolle di Lorenzini, consentendo di aumentare la sensibilità ai campi elettrici e a quelli geomagnetici
- Scopo alimentare: il cranio, grazie alla particolare forma, viene utilizzato da alcune specie di squali martello, per bloccare le prede sul fondo, per cibarsene più agevolmente
Attività giornaliere degli squali martello
Di particolare interesse sono le 2 diverse attività che gli squali martello smerlati (S. lewini) svolgono, nell’arco delle 24 ore: Le attività cambiano in base alle fasi luminose della giornata.
Fase Diurna – Movimento Point to Point
Durante tutta la fase diurna della giornata, gli esemplari di S. lewini formano grandi gruppi e nuotano contro corrente da un preciso punto del sito di aggregazione (Punto A), ad un altro punto del sito (Punto B), dove la corrente scema di intensità. Raggiunto il Punto B, il gruppo (schooling) inverte il nuoto e, questa volta a favore di corrente, ritorna verso il Punto A. Questo movimento, denominato “Point to Point“, viene ripetuto innumerevoli volte durante l’intera fase luminosa della giornata.
La Fase Diurna, e il movimento correlato, hanno tre finalità:
- Output energetico: l’elevata idrodinamicità e la bassa frequenza di nuoto, permettono agli esemplari di mantenere contenuto il consumo energetico per molte ore, ottimizzando le riserve energetiche
- Ossigenazione sanguigna: il grande afflusso di acqua sulle branchie, grazie al nuoto controcorrente, permette di aumentare il tasso di ossigeno nel sangue
- Attività sociali: le schooling favoriscono le attività sociali correlate alla riproduzione
In alcuni siti (prevalentemente quelli del Centro America), le grandi aggregazioni sono caratterizzate da una Sex Ratio (rapporto numerico maschi/femmine) di 1 a 6: quindi, mediamente in ogni gruppo ci sono 6 femmine per ogni maschio maturo: questa sproporzione numerica spinge le femmine mature a “confronti gerarchici”, per potersi posizionare al centro della schooling, dove si trovano i maschi adulti.
Questi “confronti gerarchici”, denominati Hit, sono caratterizzati da morsi che le femmine dominanti infliggono alle “non dominanti”, per spingerle ad allontanarsi dal centro del gruppo. Questi morsi, nel tempo, vengono infestati da parassiti, ed è per questo che le femmine adulte, spesso fortemente segnate dai morsi, si avvicinano agli spot coralligeni, per farsi eliminare i parassiti dai pesci pulitori (Cleaning Station).
Fase Notturna – Movimento Verticale
All’imbrunire, il gruppo di squali martello S. lewini si disgrega e ogni esemplare si allontana dal sito di aggregazione e va a caccia a profondità comprese tra -100mt e -300mt (Movimento Verticale). Ogni esemplare caccia singolarmente, prediligendo cefalopodi (70%) e pesci ossei (30%): al termine della Fase Notturna, con l’arrivo delle prime luci dell’alba, ogni singolo squalo, utilizzando la sua sensibilità al magnetismo terrestre, ritorna al sito di partenza (sito di aggregazione), seguendo i campi geomagnetici prodotti dal sito di aggregazione (isola o reef).
Le 24 ore degli esemplari di S. lewini sono quindi caratterizzate da due Fasi, correlate alla luminosità, e ad ogni fase corrisponde un movimento diverso del nuoto: gli esemplari trascorrono la Fase Diurna formando gruppi caratterizzati da un’intensa attività sociale mentre, durante la Fase Notturna, cacciano singolarmente. Lo studio delle attività sociali di S. lewini, obiettivo del progetto di ricerca Danishark, è quindi particolarmente interessante per la sua complessità e per la difficoltà di osservazione e di studio.
Caratteristiche dei siti di aggregazione
La biologia dello squalo martello S. lewini risulta essere particolarmente complessa e ruota intorno alle schooling e alle conseguenti attività sociali: questi squali però, vivono e si raggruppano solo in siti dove vi sono due caratteristiche fondamentali: la presenza di reef o isole in mare aperto (picchi delle dorsali oceaniche), e forti correnti stagionali.
Reef e isole
Gli esemplari di squalo martello smerlato si raggruppano formando le schooling sempre intorno a reef affioranti (o semi affioranti) o a isole che sono picchi di dorsali oceaniche (catene montuose sommerse): questo perché queste strutture (isole e reef) determinano picchi geomagnetici che gli squali utilizzano per orientarsi all’alba di ogni mattina, per ritornare ai siti di aggregazione e ricostituire il gruppo disgregatosi la sera prima. Le isole e i reef fungono quindi da “radiofaro” per gli esemplari di S. lewini, che dopo aver trascorso l’intera notte a caccia, riformano le schooling intorno al loro sito di aggregazione.
Correnti stagionali
L’altro fattore fondamentale per la presenza delle schooling intorno ai siti di aggregazione (isole e reef) sono le correnti stagionali: queste sono necessarie per garantire il nuoto controcorrente, caratteristico della Fase Diurna, garantendo agli esemplari la capacità di aumentare il tasso di ossigeno nel sangue e di mantenere basso il consumo energetico, in vista della nottata di caccia.
Per poter osservare le schooling di squalo martello (S. lewini), è quindi necessario immergersi in siti specifici (isole o reef in mare aperto), caratterizzati da forti correnti (quasi sempre a presenza stagionale): l’impatto di queste correnti contro le pareti di isole o reef determina poi l’intensificarsi delle correnti stesse, creando aree con maggior afflusso d’acqua, che gli animali utilizzano per il Movimento Point to Point, tipico della Fase Diurna.
Esempio: l’Isola di Mikomoto
Un esempio chiaro di “sito aggregativo” di S. lewini è l’Isola di Mikomoto in Giappone, oggetto di una spedizione Danishark nell’ottobre 2024.
Mikomoto è una piccola isola disabitata, situata a sud-ovest di Tokyo, ed è la punta emersa di una dorsale oceanica (catena montuosa marina): tra i mesi di giugno e ottobre, Mikomoto viene letteralmente investita da una corrente oceanica calda, molto intensa, che si chiama Corrente di Kuroshio, che permette la presenza di enormi schooling di S. lewini.
Nel corso della spedizione a Mikomoto, il Gruppo Danishark si è immerso più volte nell’area di aggregazione, potendo osservare e filmare una schooling di oltre 200 esemplari di S. lewini: le condizioni meteomarine hanno permesso di osservare fino a 4 movimenti “Point to Point” del gruppo di squali, osservazione molto rara da poter fare in una singola immersione.
Conclusioni e prospettive future
Dopo 23 anni di spedizioni e oltre 800 immersioni dedicate esclusivamente allo studio di S. lewini in 3 continenti, la conoscenza della biologia di questa specie è senza dubbio una parte distintiva dell’Associazione Danishark: sono ancora però innumerevoli gli aspetti delle schooling non conosciuti, che osserviamo da anni, ma a cui non riusciamo a dare una spiegazione o una lettura scientifica.
Ogni anno Danishark organizza nuove spedizioni di ricerca: a novembre 2025 saremo nuovamente in Messico, per la seconda spedizione nell’arcipelago della Revillagigedos (Socorro), mentre a marzo del 2026 il Gruppo Danishark si immergerà nel reef di Tubbataha (Mar di Sulu – Filippine), sempre con l’obiettivo di aumentare la conoscenza della biologia dello squalo martello smerlato che regala, ad ogni immersione, un’emozione unica.
Per informazioni sulle spedizioni e su tutte le attività dell’Associazione Danishark Elasmobranch Research, scrivere a : info@danishark.it
Articolo originale pubblicato su ScubaZone82